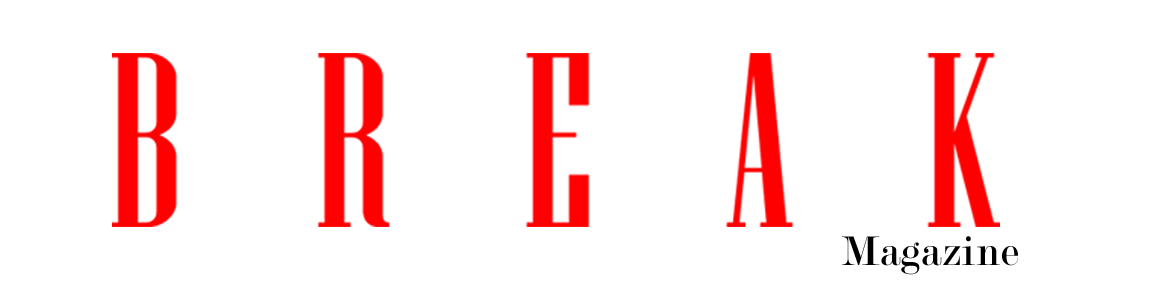Quentin Tarantino, piaccia o meno, è sempre più il mondo e il tempo che vuole lui. Sempre più una bolla protetta dalla storia reale del mondo moderno ma rifiltrata dalla cinefilia e dalla passione per tutto quello che è considerato minore. Sempre più universo parallelo. Sempre più al di fuori e al di sopra dei generi come fossero un unico flusso, una totalità indistinta. Con l’intenzione di sciogliere tutto in un organismo unico, l’ambizione di un cinema che diventa una cosa sola, una fusione unitaria. Per questa ragione in apertura non abbiamo scritto “il cinema di Quentin Tarantino”, proprio perché il regista e il suo cinema non sono realmente separabili, ma sono ormai quasi un’unica entità.
Once upon a time… in Hollywood non fa eccezione, anzi. Amplia questa dimensione. Visivamente è un film sontuoso, abbagliante, energico. Siamo nelle strade assolate della California, quelle intorno a Hollywood e le sue ville, nel 1969, l’anno dell’ascesa alla Casa Bianca di un presidente reazionario come Richard Nixon, dopo le speranze rappresentate dai fratelli Kennedy e da Martin Luther King – tutti assassinati nel decennio che si chiude – e di un intensificarsi della guerra in Vietnam.
Decennio magico di crisi e rinascita
Ma è anche l’anno dell’allunaggio e della crisi dell’industria di Hollywood che porta all’affermarsi di quella che è stata definita la New Hollywood, un movimento di grande energia che criticherà e vivisezionerà la società americana insieme al sistema degli studios: un decennio magico di crisi e di rinascita da cui usciranno fuori Roger Corman (che ne fu l’iniziatore) e Sam Peckinpah, Francis Ford Coppola e Martin Scorsese, Peter Bogdanovich e Arthur Penn, Brian De Palma e Michael Cimino, George Romero e Steven Spielberg, fino ad arrivare, tra le ultime propaggini, a Oliver Stone, il quale comincia la sua carriera nel riflusso degli anni ottanta, riflusso che nel cinema americano pare non esser mai terminato del tutto.
Tutto questo nel nuovo film di Tarantino non c’è, come non c’è quasi, se non per piccole allusioni, riferimento alle tragedie storiche appena citate. Ma il fatto che la New Hollywood sia fuori campo come riferimento cinematografico, forse fa ancor più sentire la sua presenza, nel bene e nel male.
Come ha fatto in molti altri film, Tarantino fa qui riferimento alle serie b televisive, nella fattispecie la serie tv western Lancer (il cui protagonista, James Stacy, è interpretato nel film da Timothy Olyphant), anche se i protagonisti del film, interpretati da Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, sono rispettivamente attore protagonista e controfigura-cascatore del primo in una serie western immaginaria, Bounty law, idealmente prodotta tra il 1958 e il 1963.
Il primo è ora dimenticato e fallito, il secondo è abituato a non esser considerato, perché cinematograficamente nato nell’oblio, e quindi ora in miglior forma. Un meccanismo che ricorda The hateful eight, che si riferiva alla celebre serie tv western Bonanza oltre che, come qui, agli spaghetti-western di Sergio Corbucci, regista a cui del resto già si riferiva in maniera evidente fin dal titolo con _Django unchained__._
Tra fiction di serie b e serie c, Tarantino in realtà trasfigura tutto questo come un artista della pop art, mutando il medio o il mediocre in una visione da cinema di grande budget, con un’eleganza e un’energia visiva degna di certo cinema della New Hollywood. Molto merito va al direttore della fotografia Robert Richardson che, proveniente dall’horror politico di Wes Craven, è poi divenuto direttore della fotografia di tutti i film di Oliver Stone, da Salvador (1986) fino a U turn – Inversione di marcia (1997). Un regista, Stone, che ha riletto la storia statunitense come un film horror e che ha cominciato non per caso con l’horror (Seizure, 1974, e La mano, 1981). Poi, da Kill Bill, Richardson è passato a collaborare in maniera fissa con Tarantino.
Potenza criticata ma innegabile
Quanto ci sia in questa trasfigurazione dell’intensità, del ritmo (soprattutto nella prima parte) e della profondità di quel cinema ribelle, è ben più dubbio. Qui a Cannes anche critici molto amanti del cinema Tarantino hanno espresso forti critiche riguardo alla mancanza d’intensità e di riferimenti cinematografici più ampi, e più ancora alla scarsa etica e moralità nel riscrivere la storia, in questo caso l’omicidio di Sharon Tate nella villa di Roman Polanski commesso dall’efferata setta Family Manson. Ma Tarantino lo ha sempre fatto, in particolare nell’ucronia di Bastardi senza gloria dove Hitler e Goebbels finiscono assassinati.
La libertà che si prende Tarantino è ormai totale, si fa labile la distinzione tra un genio leggero, o superficiale, e un genio innamorato dell’uomo e del cinema che cerca di creare un’utopia che sovverte l’ineluttabilità della storia. Il suo cinema, da molto tempo, trasmette un senso ludico radicale quanto di vuoto interiore, con l’eccezione di Jackie Brown.
Tuttavia la potenza del suo stile è innegabile anche se nella prima parte si guarda un po’ l’orologio ma poi ci si diverte davvero. Ma non solo. È proprio nella parte notturna con Sharon Tate che Tarantino seduce di più riuscendo per la prima volta a evocare atmosfere e creando nella successione di situazioni farsesche un mondo, una bolla a metà tra l’horror e il fantastico, dove si vede tutto il talento visivo di Tarantino e Richardson.
Tra la grandezza, presunta o reale, del cinema western che DiCaprio pensa di interpretare sul set e il mediocre ma divertente western reale della cittadella western delle giovani donne – ma situata fuori dal set – in cui finisce invece Brad Pitt, non c’è distinzione, siamo in un unico film senza soluzione di continuità. Così come la storia e il tempo del mondo reale sono un unico sogno-incubo riscritto e rinchiuso in una bolla, o utero materno protettivo creato dalla cinefilia, molto umano quanto forse un po’ immaturo.
Immaturo ma al tempo stesso anche molto bello, quasi una forma nuova di cinema potenziale che ha una sua poesia ma che, proprio per questo, si vorrebbe che affinasse per farlo divenire in futuro qualcosa di più profondo e intenso.
E raggiungesse, magari superandoli, quei maestri del cinema popolare di genere giapponese che sono Seijun Suzuki e Kenji Fukasaku – capaci di creare grandi e raffinate invenzioni di stile insieme a rappresentazioni profonde – in Kill Bill da lui saccheggiati e omaggiati (anche qui come distinguere le due cose?).
Un po’ vano, geniale maestro dell’esercizio di stile a partire da Kill Bill, il potenziale di Tarantino è così enorme, così unico nella storia del cinema per il suo globalizzare le frontiere sia geografiche sia temporali, che porta a desiderare che questo universo di simulacri dove ha annullato ogni porta e forse ogni muro, veicoli oltre al ludico anche qualcosa di intenso, realmente interiore e visionario come, per esempio, riesce al cinema di un David Lynch.
Qualche parola su due altri film del concorso. Parasite di Bong Joon-ho è una splendida sorpresa del Concorso, e siamo molto felici che Academy Two ne abbia comunicato in questi giorni la distribuzione in Italia. Questo originale autore sudcoreano che usa il cinema di genere e di serie b in maniera un po’ politica (come negli anni settanta e all’inizio degli ottanta faceva, pur tenendo conto delle tante differenze, il cinema di John Carpenter, omaggiato di persona qui a Cannes), dopo alcune produzioni internazionali meno convincenti (Snowpiercer e Okja) torna a una produzione autoctona con un lungo film, una commedia satirica notevolmente ben diretta e dall’ottimo ritmo, sulla divisione tra classi povere e ricche nella società sudcoreana. Un film coraggioso, soprattutto in quel paese – anche perché è chiaramente una produzione rivolta a un vasto pubblico – dal ritmo crescente e dai continui ribaltamenti (finale compreso), ma sempre produttori di senso.
Infine, Roubaix, une lumière (Oh mercy!) del francese Arnaud Desplechin. Desplechin, figlio della nouvelle vague e poco distribuito in Italia, si cimenta qui in un bel film su una squadra di polizia, come abbiamo già scritto a proposito de Les misérables, guidata da un agente di origini magrebine. Il film comincia proprio negli ambienti dell’immigrazione ma poi si muta in un originale e inatteso lavoro quasi intimista, delicato a tratti, tra il poliziotto e due giovani donne lesbiche finite sotto inchiesta.