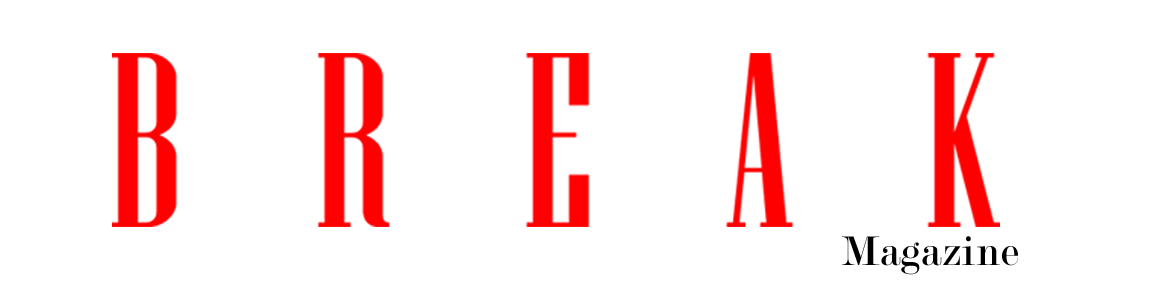Tra qualche istante la scena finirà e l’attrice si struccherà, si cambierà e tornerà alla sua vita quotidiana. La serie invece alla fine della lavorazione verrà mandata a cercare fortuna nei Paesi del Golfo: ispirata a un leggendario e sanguinario predone beduino (l’equivalente dell’“Uomo Nero” che spaventava i bambini italiani di qualche decennio fa), “Debbah Ighleis” è pensata per i telespettatori della penisola araba, che sono particolarmente affezionati alle storie ambientate nel leggendario passato delle tribù nomadi. E contribuirà a far sopravvivere tra i diretti interessati quell’immagine orientalista della vita che fu codificata più di un secolo fa da viaggiatori e colonizzatori europei.
Un modello che in Occidente, dopo le critiche di Edward Said, è stato messo violentemente in discussione, ma è invece ancora oggi amatissimo dagli arabi più conservatori. Come sono quasi sempre i produttori di queste telenovelas: «Gli imperi mediatici sono perlopiù finanziati da capitali provenienti dalle monarchie tradizionali dei Paesi del Golfo, che impongono la loro impronta conservatrice alle musalsalat arabe», ha scritto in un saggio Alexandra Buccianti, studiosa dei media locali.
Le musalsalat hanno un peso sempre maggiore nei palinsesti televisivi dei Paesi arabi e per questo se ne girano sempre di più. Andrea & Magda – la coppia italo-francese autrice del reportage “Arabian Tales” che pubblichiamo in queste pagine – ha dedicato finora due anni per raccontarle, visitando una decina di set tra Egitto e Medio Oriente. Un lavoro finanziato dal Centre National des Arts Plastiques e dalla Fondation Les Treilles per mettere a fuoco le diverse anime di un settore del tutto sconosciuto allo spettatore televisivo occidentale.
Ad attirare i produttori di musalsalat è il mercato potenzialmente molto ampio: i Paesi di lingua araba sono più di venti, i canali televisivi tradizionali oltre trecento e i potenziali spettatori più di duecento milioni. La lingua non è esattamente la stessa per tutti, ma finora questo non è stato un problema. All’inizio le musalsalat parlavano prevalentemente egiziano, la lingua della più fiorente industria cinematografica dell’area. Poi sono passate a un arabo classico, modellato sulla letteratura e sul giornalismo televisivo alla Al Jazeera. Ora invece stanno scoprendo il gusto di conservare la parlata del Paese produttore, che spesso finisce per diventare anche quella di un determinato genere di storie: così succede che in televisione i beduini parlino sempre giordano, i poliziotti libanese, i migranti siriano, le coppie di innamorati egiziano…
Ogni produzione nazionale infatti tende a specializzarsi, andando incontro non solo ai gusti del pubblico ma alle proprie potenzialità. Grazie alla grande tradizione di cinematografia, l’Egitto ha un know-how unico per i set artificiali. Nel deserto vicino alle piramidi nascono dal nulla palazzi che diventano la location per storie ambientate ai tempi della colonizzazione inglese, come “Wahet Al Gheroub” (Oasi del tramonto”). Mentre per la serie “Al Halal” (“Ciò che è permesso”), che racconta una storia di poveri ma belli nel quadro di un genere amatissimo dal pubblico locale, è stato costruito dal nulla un intero vecchio quartiere del Cairo, con tanto di soffitti macchiati di fumo e intonaci pieni di crepe.
Invece in Libano – dove hanno trovato rifugio molti cineasti siriani, dai registi agli attori alle maestranze in fuga dalla guerra – i nuovi arrivati hanno importato l’abitudine a girare serie più realistiche, legate all’attualità e alla cronaca nera, come “Jareemat Shagaf”: che sia un attentato o una visita a una tomba, viene girato sempre per strada o in un vero cimitero. I ricchi libanesi mettono volentieri a disposizione delle troupe che cercano location i loro appartamenti decorati con lusso, se non con buon gusto, per drammi d’amore come “Amr al leila” (“Il signore della notte”).
Produrre le soap opera in casa ha molti vantaggi, per il pubblico dei Paesi arabi. Prima di tutto, perché si evita il pericolo dei messaggi inquinanti portati da certe fiction: dal consumismo americano alla passionalità messicana. Anche con le storie che vengono dal mondo musulmano non sempre si può stare tranquilli dopo il grande scandalo di “Noor”, doppiata in siriano e trasmessa nel 2008 con un successo entrato nella leggenda: l’ultima puntata è stata vista da 85 milioni di persone; secondo alcuni calcoli, metà delle donne di tutto il mondo arabo ha sintonizzato la televisione su quel canale. La trama di “Noor” sembrerebbe castissima a un pubblico occidentale. Malgrado questo, la serie ha attirato prima le forbici del censore, poi gli strali delle autorità religiose: dal divieto di entrare in moschea con le magliette decorate con i volti dei protagonisti, alla minaccia di una fatwa – una condanna a morte – lanciata dal capo dei tribunali religiosi dell’Arabia Saudita contro i proprietari della televisione che la trasmetteva. Una condanna che ha creato un problema politico non da poco, visto che i padroni del media sauditi sono tutti imparentati con la famiglia reale.
Nessun rischio del genere con le musalsalat “muslim friendly”, prodotte tra Egitto e Medio Oriente. Non c’è traccia di situazioni peccaminose nella serie egiziana “Li a’la Se’er” (“Il prezzo più alto”), che pure segue una coppia di sposi dalla luna di miele alle prime tentazioni di adulterio. E nemmeno nel libanese “Ya rayet” (“Lo voglio”), storia dell’amore contrastato tra una ragazza del posto e il figlio di profughi siriani. Malgrado l’autocensura sui temi più sexy, per soddisfare il pubblico sempre più esigente le produzioni si aprono a temi di attualità scottanti e le conseguenze cominciano a farsi sentire. Come quando in Libano la serie “Qawalis al Madina” (“Dietro le mura della città”) ha romanzato una storia vera, che aveva per protagonista un giudice molto noto e dichiaratamente omosessuale.
Sbocchi sul mercato occidentale per la produzione di musalsalat non sono previsti, per ora. Anche se Babel, uno dei canali visibili su Sky, ne ha programmate tre, in arabo con sottotitoli italiani, durante l’ultimo Ramadan: il mese del digiuno è per tradizione anche quello più dedicato alla televisione, con i dati di ascolto che raddoppiano in tutti i Paesi musulmani e serie di trenta puntate prodotte apposta per essere trasmesse una a sera. Per non parlare della trasmissione sul web, su Youtube o sul canale di Google dedicati esclusivamente alle musalsalat, che così vengono messe a disposizione di tutti gli arabofoni sparsi per il mondo: una diaspora che va dal Cile all’Olanda, dalla Svezia all’Australia. E forse presto anche loro, come succede agli occidentali abbonati a Netflix, inizieranno a farne malsane scorpacciate: come si dirà “binge watching” in arabo?